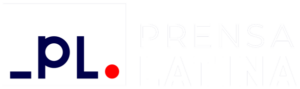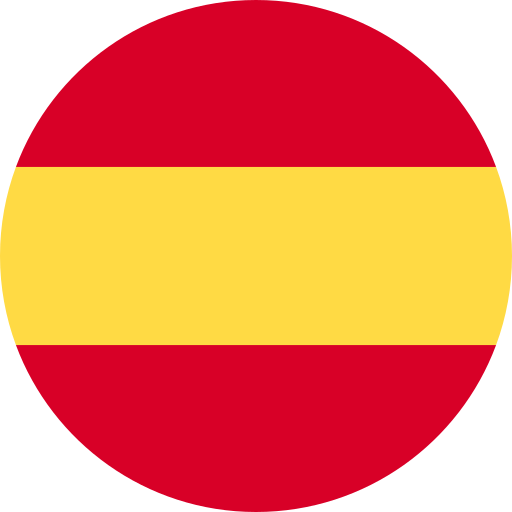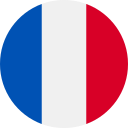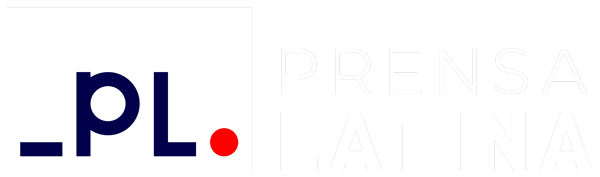Questo paese, creato nel 1948 come risarcimento al popolo ebraico dopo l’olocausto causato dal nazismo con sei milioni di morti negli orribili campi di concentramento, all’inizio non ha svolto il ruolo terrificante che presenta oggi. Come risultato dei negoziati franco-britannici volti a gestire le riserve petrolifere della zona, è apparso il nuovo stato, che già soppiantava il popolo palestinese, ma senza presentare il carattere bellicoso di oggi. È stato dopo la guerra del Sinai, nel 1956, che gli Stati Uniti – già allora una potenza globale, di fronte alla sua acerrima rivale, l’Unione Sovietica, nella Guerra Fredda – sono entrati in Medio Oriente, cercando di dominare le fonti dell’oro nero.
Da quel momento in poi, sostituendo definitivamente Gran Bretagna come grande potenza imperiale, Washington ha cominciato ad insediarsi sul trono nella regione. Dal 1963, con la presidenza di John Kennedy, il rapporto della Casa Bianca con Tel Aviv è diventato organico. Lì, ed in modo progressivamente crescente, lo stato d’Israele diventa l’avamposto statunitense in un’area che considera vitale per i suoi interessi: una riserva petrolifera, punto dove bloccare la presenza sovietica in quel momento, ed oggi dove esiste la possibilità di ostacolare lo sviluppo cinese degli idrocarburi.
Non è una novità che Israele riceva molti aiuti militari statunitensi: quattro miliardi di dollari all’anno (il 17% degli aiuti esteri globali forniti da Washington). Attraverso complessi legami di interessi, la lobby ebraica della superpotenza, dotata di grande potere di influenza, è riuscita a convincere sia l’amministrazione federale che importanti settori dell’iniziativa privata a destinare ingenti risorse ad Israele. L’investimento non è gratuito. Israele, al di là dei settori pacifisti che anche esistono, come stato nazionale adempie perfettamente il suo mandato, peraltro non molto nascosto, di difesa degli interessi extraregionali: è il gendarme armato fino ai denti che la geostrategia statunitense ha assegnato alla regione, anche con armi nucleari, ufficialmente non dichiarate, ma di fatto esistenti (dati non ufficiali parlano di almeno 400 testate atomiche).
Ma ora le cose stanno cambiando.
Cina, con il suo modello particolare (“socialismo di mercato”) inizia a contendere la supremazia economica con gli Stati Uniti in condizioni di parità di trattamento. In questa prospettiva va di pari passo con l’altra grande potenza eurasiatica, Russia, una potenza militare incommensurabile, che dialoga faccia a faccia con Washington anche sul campo della guerra. L’alleanza Pechino-Mosca ha dato vita ai cosiddetti BRICS, oggi ampliati. Vale a dire: economie emergenti che, pur restando capitaliste (ad eccezione della Cina), cercano di prendere le distanze dalla supremazia statunitense. Ora il gas ed il petrolio non vengono più scambiati in petrodollari ma in altre valute. Ciò significa il declino definitivo dell’imperialismo statunitense, fino adesso dominante. Il mondo sta smettendo di essere unipolare e cerca un equilibrio multipolare.
Le petro-monarchie del Medio Oriente, come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, od una potente teocrazia come Iran, ma anche Etiopia, un importante produttore di petrolio in Africa, o Russia, un’altra importante fonte di idrocarburi, iniziano tutte a stabilire i prezzi del petrolio in valute diverse dal dollaro. Pertanto, si sta formando una nuova architettura globale in cui il capitalismo occidentale (cioè gli Stati Uniti, il loro cagnolino fedele l’Unione Europea, con in più il braccio armato della NATO) si confronta con un nuovo ordine internazionale. Il Medio Oriente ricco di petrolio può così liberarsi di Washington. In questa logica, lo stato israeliano ipermilitarizzato è fuori gioco.
In mezzo a questa nuova prospettiva che si apre con i BRICS, la guerra appare nuovamente nell’area. L’attacco del gruppo Hamas del 7 ottobre riapre il conflitto regionale. Lo stato di Israele lancia un’offensiva militare senza precedenti, massacrando la popolazione palestinese con il pretesto di annientare Hamas. Il capitalismo occidentale, con il suo silenzio complice, finisce per avallare questa mostruosità, e le Nazioni Unite, ancora una volta, appaiono inefficaci nel fermare il genocidio.
Gli Stati Uniti hanno bisogno della guerra. Un Medio Oriente in fiamme gli è funzionale, ed è per questo che sostiene apertamente l’attuale intervento militare israeliano in Palestina, ingiustificabile ed immorale. Promette addirittura di trasferire miliardi di dollari per sostenere questa aberrazione (quasi 10mila palestinesi uccisi in un mese). Israele gioca ancora una volta il ruolo del “cane pazzo, troppo pericoloso per essere disturbato”, come disse il generale ebreo, Moshe Dayan. È un messaggio alla regione: il genocidio del popolo palestinese a Gaza ed in Cisgiordania dimostra che Washington non cerca in alcun modo la pace, ma piuttosto giustifica la guerra.
Il messaggio include anche Russia e Cina, che non potranno restare imperterriti vedendo come vengono attaccati i loro partner ed i loro investimenti nell’area, siamo quindi nel preambolo di quella che potrebbe essere una nuova guerra mondiale. Un impero in declino come gli Stati Uniti oggi può ricorrere a tutto pur di non perdere il proprio scettro. La guerra totale è la sua via d’uscita?
Marcelo Colussi, collaboratore di Prensa Latina